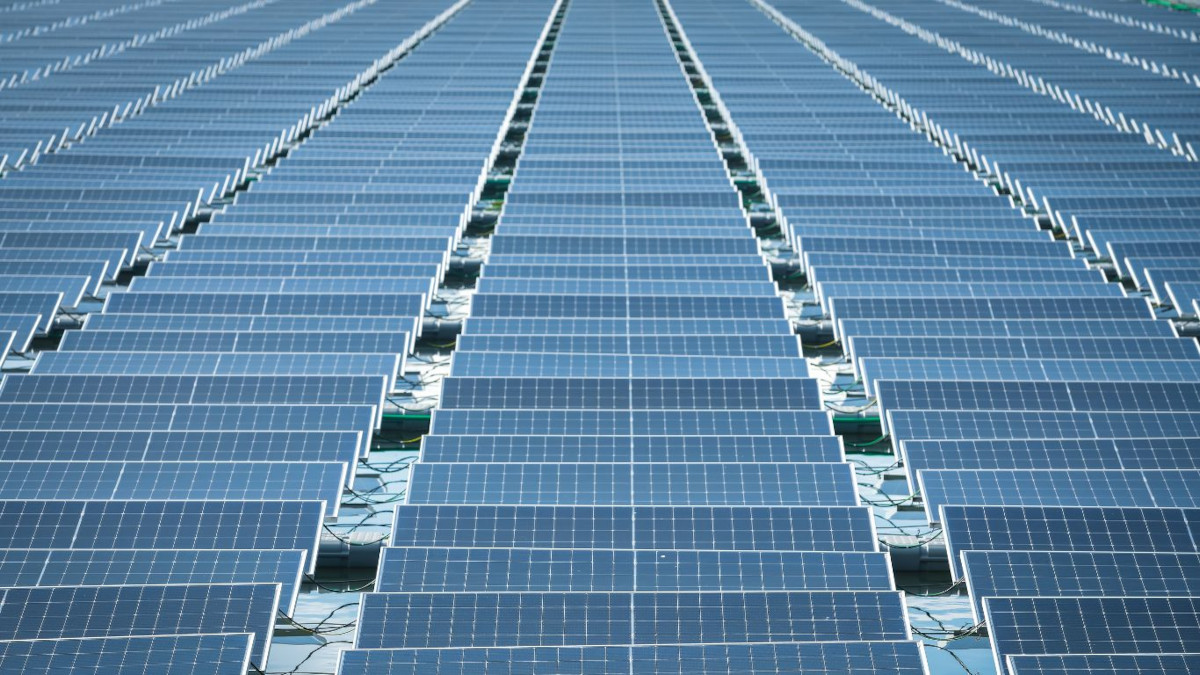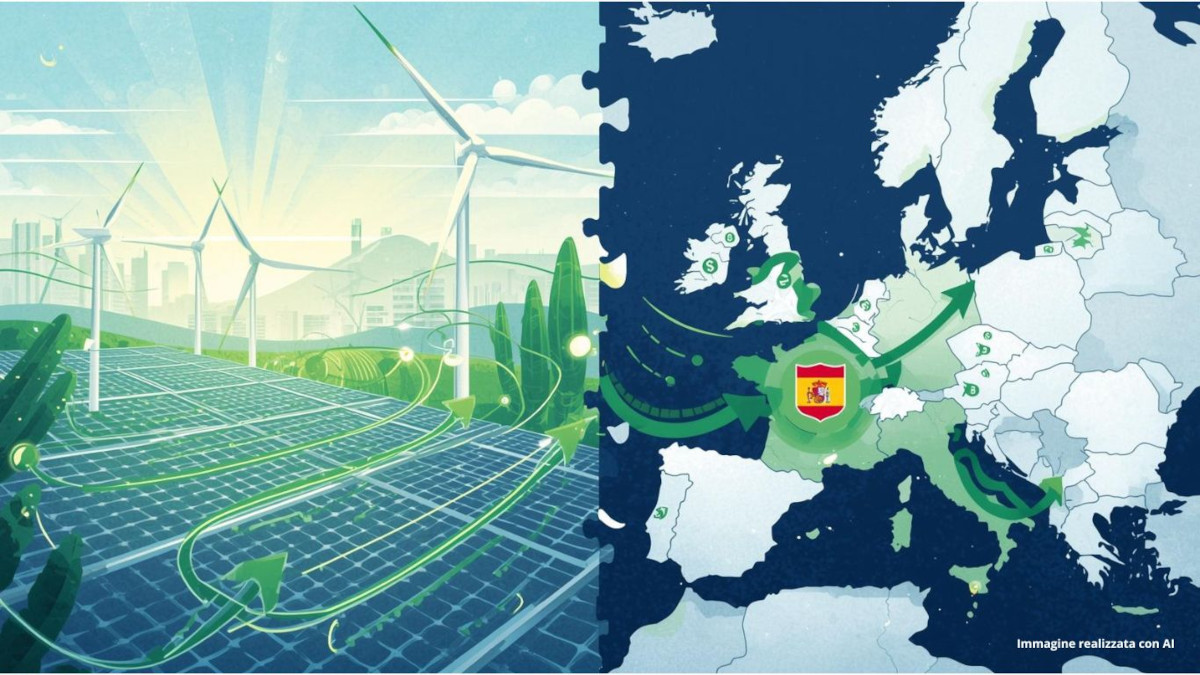- 07/08/2025
- Fadi Musa
- 0
Decarbonizzazione: Sfide e soluzioni innovative per un futuro a basse emissioni. Come l’Europa punta alla neutralità carbonica entro il 2050
Di fronte all’urgenza climatica e agli obiettivi di neutralità carbonica fissati al 2050, l’Europa ha tracciato una rotta ambiziosa. Ma se l’elettrificazione può coprire una parte importante del percorso, esistono tuttavia settori – come l’aviazione, il trasporto marittimo e l’industria – dove il passaggio alle fonti rinnovabili è tecnicamente complesso, logisticamente impegnativo ed economicamente oneroso. È in questi spazi che si fanno largo nuovi protagonisti: idrogeno, biometano, e-fuels e biocarburanti avanzati.
A fare il punto è l’Hydrogen and Alternative Fuels Report 2025, redatto dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano. Un’analisi che mette in luce le potenzialità e i limiti dei combustibili alternativi, esaminando il quadro normativo, lo stato dell’arte tecnologico e le dinamiche di mercato nei settori più difficili da decarbonizzare.
I vettori energetici a basse emissioni
Il report individua tre grandi famiglie di vettori energetici a bassa o nulla intensità emissiva: Idrogeno, sia rinnovabile (prodotto da elettrolisi alimentata da fonti pulite), che low-carbon (da gas naturale con cattura della CO₂) o bioidrogeno (da biomasse); Biocombustibili avanzati, ricavati da scarti agricoli, organici o colture non alimentari; Combustibili sintetici (e-fuels), ottenuti combinando idrogeno con CO₂ o azoto.
Sono soluzioni pensate per settori dove l’elettrificazione non arriva: trasporti pesanti, industrie energivore, impianti di riscaldamento. Ma per funzionare davvero – avvertono gli esperti – servono tre condizioni essenziali: normative stabili, tecnologie mature e una domanda di mercato solida. Se anche solo uno di questi elementi manca, la transizione si blocca.
Il viaggio della decarbonizzazione tra le nuvole
Il settore dell’aviazione rappresenta oggi circa il 3,6% delle emissioni di CO₂ dell’Unione Europea, ed è ancora alimentato quasi esclusivamente da kerosene fossile. In Europa, nel 2023, solo lo 0,3% del carburante era sostenibile. In Italia la quota è ancora più bassa: appena lo 0,13%.
Eppure, da gennaio 2025, è entrato in vigore il regolamento europeo ReFuelEU Aviation, che impone ai fornitori percentuali crescenti di carburanti sostenibili per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel – SAF), fino al 70% entro il 2050, di cui almeno il 35% da fonti sintetiche.
La normativa è ambiziosa ma lo scarto con la realtà è ampio. I carburanti sintetici (eSAF) possono costare fino a sette volte il cherosene convenzionale. La produzione resta limitata e la disponibilità di materie prime – come CO₂ catturata o idrogeno verde – è scarsa. Anche le infrastrutture di distribuzione dell’idrogeno sono ancora tutte da costruire.
Nonostante questo, il settore si muove. Sono numerosi gli accordi di lungo termine tra produttori e compagnie aeree. Aeroporti come Milano Malpensa hanno avviato progetti pilota per il rifornimento di SAF. E i fondi pubblici europei, come Horizon Europe e Innovation Fund, stanno sostenendo ricerca e sviluppo.
Decarbonizzazione tra le onde: evitare la navigazione a vista
Dal cielo al mare, la decarbonizzazione prosegue con il trasporto navale, responsabile del 4,2% delle emissioni europee. Anche qui, la dipendenza dai combustibili fossili è quasi totale. Il 99% dell’energia utilizzata proviene ancora da fonti tradizionali, e solo una quota minima è coperta da biocarburanti.
Per invertire la rotta, l’Europa ha approvato il regolamento FuelEU Maritime, in vigore dal 2025, che impone una progressiva riduzione dell’intensità emissiva dei carburanti usati dalle navi, fino all’80% nel 2050. A differenza del settore aereo, però, non si impongono carburanti specifici: ogni armatore può scegliere come ridurre le proprie emissioni.
Il principio della “neutralità tecnologica” rischia però di generare una distorsione: molte nuove navi sono progettate per il GNL (gas naturale liquefatto), anche nella sua versione fossile, il che potrebbe permettere il rispetto degli obiettivi a breve termine senza una reale svolta sostenibile.
Le alternative – ammoniaca, idrogeno, biocarburanti avanzati – esistono, ma comportano investimenti ingenti e una profonda riconversione delle infrastrutture portuali. Per il Politecnico, è urgente un maggiore coordinamento tra armatori, fornitori e autorità portuali. Senza una visione condivisa, il rischio è navigare a vista.
Decarbonizzazione sulla terra: quali soluzioni?
Infine, il viaggio della decarbonizzazione entra nelle nostre case. Nei condomini, nelle centrali termiche, nelle caldaie alimentate a gas. Qui si gioca una partita silenziosa ma decisiva: quella del calore, che in Europa ha ancora grande peso sui consumi energetici complessivi.
Nel settore industriale, il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) fissa obiettivi chiari: entro il 2030, 4 miliardi di metri cubi di biometano e un utilizzo di idrogeno rinnovabile pari al 54% dei consumi. Nel civile, invece, la priorità resta l’elettrificazione.
Ma a partire dal 2027, con l’introduzione del nuovo ETS (European Union Emissions Trading System), il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea che mira a ridurre le emissioni di gas serra, anche chi continuerà a usare caldaie a gas dovrà pagare il prezzo della CO₂, con ricadute dirette sulle bollette.
Il biometano, in questo contesto, è una delle alternative più promettenti: compatibile con le reti esistenti e sostenuto da incentivi. Il Decreto Ministeriale 2022 ha rilanciato il settore, con aste pubbliche e contributi in conto capitale. L’ultima, conclusa ad aprile 2025, ha visto la partecipazione di quasi 300 impianti, ma solo la metà potrà accedere ai fondi disponibili.
Il governo italiano ha chiesto a Bruxelles di prorogare i termini e aumentare le risorse, ma la risposta si fa attendere. Anche nello scenario più ottimistico, la produzione di biometano coprirebbe solo il 50% del target al 2030.
Servirebbero nuove aste, tariffe incentivanti e soluzioni innovative come il progetto Biometano Release, che punta a collegare produttori e industrie hard-to-abate sul modello del già esistente Energy Release.
Le rotte ci sono, ma il viaggio è appena cominciato
Il messaggio del Politecnico è chiaro: i combustibili alternativi sono essenziali per la decarbonizzazione dei settori dove l’elettricità non può arrivare. Ma il cammino è ancora in salita. Ritardi infrastrutturali, incertezze normative e costi elevati rallentano una transizione che, per rispettare i tempi imposti dal clima, dovrebbe invece accelerare.
«Servono segnali chiari e tempestivi da parte del decisore pubblico», si legge nel report. Perché se è vero che le tecnologie ci sono e le rotte sono tracciate, è altrettanto vero che siamo solo all’inizio di un viaggio complesso.